Lo straniero e il furto del lavoro In primo piano

Mi domando se, e magari a cosa sono servite le lotte operarie dei due secoli precedenti. Quando ero al liceo mi pareva che ogni cosa insegnata riguardante la storia del cammino umano fosse una pietra miliare, che ogni guerra fosse stata definitiva e che avesse risolto per sempre una questione, di sicuro in seguito ripresa, così come le battaglie per acquisire diritti e umanità nei posti di lavoro una volta combattute avessero avuto valore eterno. E ancora continuo a meravigliarmi di come si possa in maniera oscena tornare indietro, azzerare il sudore e il sangue versato davanti ai cancelli e sulle barricate, avere la spudoratezza di sminuire le sacrosante conquiste a vantaggio di miseri giochi di mercato, dove le banche, le multinazionali e l’alta finanza la fanno da padrone. Una volta si studiava per diventare capitano d’industria, persona illuminata capace nello stesso tempo di far crescere i propri profitti ma di contemplare anche le esigenze dei lavoratori, migliorando le condizioni nelle fabbriche e adeguando i salari ai nuovi stili di vita, e perfino di pensare con un gesto di umanità di realizzare qualcosa di utile per la comunità (leggi Adriano Olivetti).
Nel 1988 vide la luce un fumetto della Dc Comics, chiamato proprio Capitani d’industria; superuomini e superdonne che non ebbero vita facile, perché la loro supervita li portò a confluire in un altro gruppo di supereroi, i Suicide Squad, per poi sparire progressivamente dalle pubblicazioni. Ma al di là dell’innocente ricordo c’è da ragionare su questa categoria di organizzatori, oggi con nuova pelle e ben visti da gran parte della popolazione in quanto artefici di evoluzione e di sviluppo, ma odiati dalla rimanente parte perché obbediscono solo a cieche condizione di favorevoli profitti. I vecchi capitani forse non esistono più, e chissà che non si siano davvero estinti, anche se è da considerare che in ogni paese possono aver assunto superpoteri insoliti e particolari.
Nella maggior parte delle aziende, e parliamo anche di quelle italiane, il vero Capitano d’industria oggi è il manager, figura relativamente nuova, quello che in sostanza viene lautamente pagato per generare profitti. E prendiamo atto ancora che sono talmente forti questi personaggi da poter perfino determinare diversi aspetti delle politiche di sviluppo di una nazione; ma viene il dubbio che possano essere stati apposta sistemati lì. I manager in camicia, o tuttalpiù con maglione alla dolce vita, presiedono comitati e consigli di amministrazione, trattano direttamente con le organizzazioni sindacali, mentre i loro padroni, senza l’orologio sul polsino della camicia ma in giacca e cravatta, stanno allo stadio la domenica, guidano progetti editoriali e capeggiano organi d’informazione di livello nazionale, gestiscono holding finanziarie, si predispongono ad affrontare costruzioni di ponti, su stretto o su largo che siano; e ancora, toccati nelle loro corde filantropiche, fanno assistenza pagando giovani ragazze sventurate che spesso, quando se ne presenta l’occasione, assumono anche cariche istituzionali.
Alla luce di questa strutturazione dei vertici del lavoro torniamo alla domanda di partenza, ragionando su chi effettivamente produce lavoro. Il padrone, dunque, possiede il capitale e il manager lo fa fruttare al meglio, pensando e ripensando dove tagliare costi e provvigioni per giustificare il proprio lauto compenso e fare in modo che il suo capo ne possa approvare in pieno l’operato. E’ facile capire che il punto debole della catena, quello che non possiede e non comanda, è il nudo operario. Non scomodiamo le guerre di casta o di classe, perché appartengono a un’altra storia; oggi le condizioni di vita a cui legare le categorie sociali sono profondamente cambiate, e i solchi sono talmente vasti e profondi che addirittura cambiano sia l’aria che si respira sia quell’etere, apparentemente vago ma pregnante, che è la qualità della vita vissuta.
Non servono tante analisi per capire dov’è il problema dell’occupazione che manca, perché le condizioni di vita degli operai sono allo stadio minimo di tolleranza e perché non è vero che gli immigrati ci rubano il lavoro. Per capire forse basterebbe leggere il libro di Yvan Sagnet, giovane immigrato camerunense, dal titolo Ama il tuo sogno; s’era innamorato dell’Italia perché questa aveva tifato Camerun in una partita di quarti di finale mondiale contro l’Inghilterra, giocata a Napoli nel 1990. Sognava l’Italia come un paradiso, e negli studi aveva imparato la lingua e approfondito proprio l’economia italiana. Viene in Italia, a Torino; tifa Juventus e vorrebbe laurearsi in ingegneria, ma per mancanza di fondi viene inviato dai latifondisti del sud; è subito raccolto dai caporali che gli negano la dignità e gli rubano anche quell’idea di umanità sognata, che s’era portata dietro. Ma Yvan e gli altri braccianti alzano la testa, e magari oggi rischiano addirittura la vita. Questo solo per dire che si tratta di un lavoro infimo, che gli italiani stessi rifiutano. Dunque un lavoro che non è rubato, ma che anzi genera una diversa lotta di classe: poveri contro poveri. E lo straniero che ruba il lavoro diventa solo uno strumento deviante, tanto per continuare il vecchio gioco di distrarre le masse, e paradossalmente diventa alleato del lavoratore autoctono, ugualmente martire dell’apparato universale di abuso e sfruttamento.
UBALDO ARGENIO
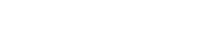
 18/10/2016
18/10/2016














