Dal Laboratorio del Gusto una speranza per lo sviluppo Società
Assaporare un prodotto tipico non significa soltanto gustarlo, vuol dire anche mordere il suo territorio, nutrirsi delle tradizioni della sua gente, crescere con la forza lavorativa che lo ha creato. Assaggiare il prodotto, esplorare l’universo degli abbinamenti con i vini locali, verificare gli esiti dell’esperimento.
È per questo che si chiama “Laboratorio del gusto”, il rendez-vous mensile della Pro Loco di San Giorgio la Molara con quattro condotte di Slow Food, che ha proposto la degustazione di un formaggio tipico sannita: il Pecorino di Laticauda.
Il Fortore è infatti la culla dove si preserva la maggior parte degli esemplari di una razza ovina autoctona tra le più antiche del nostro Paese. Se è vero che la nostra cultura sta reclamando un ritorno alle origini contadine, così come alla riconciliazione con la campagna, per troppo tempo considerata un ambiente poco edificante per lo status symbol, è necessario sapere anche che nel Sannio vive un ovino, pronipote di una razza nordafricana importata dai borboni in Italia, probabilmente ai tempi di Carlo III, ed incrociata con una locale appenninica, fino ad ottenere, per l’appunto, la Laticauda.
Il suo nome deriva dal latino “latis” “cauda”, coda larga, una riserva di grassi trattenuti in questo enorme serbatoio, per conferire al latte ed ai suoi derivati una suadenza ed una leggerezza uniche per la specie.
Il delicato formaggio che da questa razza si produce, è stato dunque abbinato ad alcuni vini bianchi del Taburno, nella cornice dell’ex convento dei Domenicani, mentre all’interno dell’atrio principale dello stesso edificio, si svolgeva il consueto mercatino del Tipico, come ogni prima domenica del mese.
E via, note di frutta secca abbinate alla falanghina, e ancora… man mano che la stagionatura degli assaggi aumentava, un vino sempre più robusto, fino all’ultima degustazione, dodici mesi di buon formaggio accompagnato dal famosissimo sidro di mela limongella.
È nel Fortore, dunque, al confine col Tammaro, all’interno del surreale scenario dell’antico Sannio ormai votato all’energia eolica e costellato di pale che girano disinvolte, scusando la propria presenza con la fornitura di energia più pulita, è lì, che persiste una delle tradizionali produzioni di specialità indiscusse, suggestive, sconosciute.
Molto spesso i sanniti vengono ricordati come un popolo fiero, rivendicatore, temerario. Un DNA che compone intimamente ciascun abitante di questa provincia, tuttora tenacemente attaccato alle proprie origini. Ma per quale motivo? Solo per la squadra di pallone? Per l’indomita capacità di opporsi all’invasore? O perché come noi non c’è nessuno?
Cosa succederebbe, allora, se questo territorio smarrito, alla ricerca della sua identità, la ritrovasse, dopo tutti questi anni di smarrimento dovuto all’illusione, di poter trovare lavoro, casa, famiglia, soltanto lontano dalle sue tradizioni, magari appannaggio di fabbriche fantasma, dal ciclo di vita pari agli archi temporali della 488?
Non c’è sviluppo senza identità. Non c’è identità senza conoscenza della propria provenienza. E chi l’ha detto che quest’ultima si impara solo dai libri di storia? La mente, si sa, si lascia imprimere meglio dalle forti sensazioni, meglio ancora se quelle del buon palato.
MARIA ELENA NAPODANO
MARIA ELENA NAPODANO
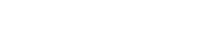
 15/05/2006
15/05/2006













