A via Annunziata crolli, degrado e oblio Cronaca

Via Annunziata, negli anni Trenta del secolo scorso era la via degli innamorati, dal punto di vista storico invece essa costituisce il decumanus inferior della città romana, che partiva dall’arce, ancora in parte visibile, inglobata nella Rocca dei Rettori. La strada prende il nome dalla bella chiesa omonima, che il pio popolo di Benevento chiama ancora Santa Rita, per la statua assai venerata che qui si conservava, prima d’essere trasferita, nella brutta costruzione sita alla Pacevecchia.
Percorrendo Via Annunziata nel tratto che dalla Rocca scende appunto verso la chiesa, sembra di entrare in un’altra dimensione.
Il selciato è ancora costituito dal nero lucido basalto, lo stesso che lastricava il Corso Garibaldi, fino a una ventina d’anni fa. Tranne alcuni palazzi degli anni Sessanta del ‘900, il resto degli edifici è rappresentato da edifici del Sette-Ottocento. Rare automobili interrompono talvolta la pace che regna, resa più suggestiva dall’ombrosa e muscosa frescura.
Le mura delle case sono costellate di antichi reperti: fregi, rocchi di colonne, iscrizioni, stele funerarie romane. I volti dei nostri concittadini di duemila anni fa ci guardano con la fissità della pietra e con preoccupazione per ciò che accade sotto il loro sguardo. Infatti in piena pandemia, a novembre del 2020, crollò un intero edificio in Vico Arechi, deliziosa stradina medievale che si avvolge attorno al lato destro di Via Annunziata e che la collega con l’Hortus Conclusus. Il vico reca ancora l’acciottolato settecentesco, che rivela la vetustà di questo luogo. L’abbandono, l’incuria hanno fatto il resto.
Obbligati alla residenza coatta della prima ondata pandemica, forse non tutti noi beneventani ci siamo resi conto del disastro che sta avvenendo in quella antica zona della nostra città. Le macerie del crollo sono state sgombrate e poste in ordine nello spazio lasciato dalla costruzione, ma tutt’attorno altri edifici minacciano di cadere, ormai ridotti a vuoti involucri. E dire che la zona è anche abitata e non deve sentirsi troppo sicuro chi vive lì, con il pericolo di essere travolto da un crollo quasi inevitabile, per com’è la situazione.
Oltre al pericolo per l’incolumità degli abitanti, anche i monumenti di cui parlavo prima rischiano di sgretolarsi e con essi scomparirebbe una preziosa fonte documentaria. Ad esempio, proprio di fronte al palazzo crollato in Vico Arechi, su un edificio è incassato un reperto di grande interesse: si tratta di un raro monumento funerario a fregio dorico, recante un’iscrizione dedicata a un veterano dedotto con la colonia triumvirale, dopo il 42 a. C., l’iscrizione è registrata nel repertorio realizzato da Theodor Mommsen come CIL IX 1604.
Mario Torelli nel 1968 pubblicò uno studio su questa tipologia archeologica, Monumenti funerari romani con fregio dorico; egli cercò di localizzare l’iscrizione beneventana, ma non riuscì a trovarla, perché all’epoca era stata ricoperta da intonaco. Fortunatamente, messa allo scoperto, è oggi visibile ed è stata studiata dal prof. Giuseppe Camodeca, emerito dell’Università L’Orientale di Napoli. Vi rendete conto di quali preziose testimonianze abbiamo qui? Calpestiamole, lasciamo che si sgretolino e daremo ragione al grande filologo Mommsen, che ci apostrofò con queste dure parole: “Non ho visto mai gente più disamorata delle sue patrie memorie dei beneventani!”
PAOLA CARUSO
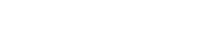
 10/02/2022
10/02/2022













