La leggenda di Pietro Mennea di scena a Montefusco Sport
Meno petulante di un classico nonnetto e decisamente più incisivo, Pietro Mennea, che nel presentare il suo libro “Il doping e l’Unione Europea” a Montefusco, ha parlato di sport autentico, in un momento in cui le cronache del calcio non giocato riempiono pagine di giornali, con fiumi di parole, dai facili commenti ex-post, alle esacerbanti intercettazioni telefoniche pubblicate senza ritegno.
Quel 20 maggio 2006, sembrava un po’ ET, Mennea, di fronte ai piccoli giocatori della Scuola Allievi Calcio, che lo guardavano affascinati, ma pieni di interrogativi.
Molti di loro non sanno, né possono sapere, che chi gli parla è stato uno degli ultimi campioni “genuinamente” generati dallo sport. Un corridore Campione d’Italia, d’Europa, olimpico, nel 1980 a Mosca, con quel magnifico 19’72” sui 200 piani che stabilì il record del mondo che durò fin quando, ben diciassette anni dopo, un giovane, poi squalificato per doping in una gara successiva, lo migliorò senza mai chiarire se in quella importante circostanza avesse preso sostanze o no.
Avvenne forse proprio in quel periodo, il cambio d’era che segnò il passaggio dai risultati ottenuti con l’allenamento costante allo studio del tessuto della tuta e delle condizioni della pista.
Migliorare le performance non è stata questione di look per lui, che come ha raccontato, si allenava per più di sei ore al giorno per 350 giorni all’anno. E alla faccia dei comparsanti, rifiutava pure gli inviti alla Domenica Sportiva per non perdere tre giorni di training, una regolarità paziente che lo ha portato lontano e…veloce.
La presentazione del libro ha offerto l’occasione per parlare di sostanze proibite nella qualità o nella quantità, in presenza di medici ed allenatori, poi, il momento del passaggio del testimone.
“Ai giovani dico che il risultato si ottiene con molto lavoro, costante, col sacrificio, e col tempo. Non lasciatevi affascinare dai facili traguardi – ha continuato Mennea – perché lo sport non è immagine, non conta apparire ed essere il più invitato. Per avere creduto in questo, sono stato spesso accusato di essere un tipo difficile, scostante, ho dovuto anche rinunciare a cariche importanti, ma ho tenuto duro fino a dimostrare quello che valevo. Nel libro ho scritto tutto. Grazie, al mio editore, per il coraggio che ha avuto di pubblicarlo”.
Pietro ha sempre sostenuto la lealtà nello sport, senza mai paura di dire la verità. Racconta allora delle telefonate che arrivavano dall’alto ai suoi superiori perché gli fossero revocati gli incarichi, di quando gli dicevano che non avrebbe mai fatto carriera nelle federazioni, o ancora di quell’episodio in cui offrirono ai suoi avversari una Ferrari in palio per chi fosse riuscito a battere il suo primato.
“Mi ricordo – ha detto – che mi invitarono, dopo aver spianato un’intera collina e costruito appositamente una pista, ad assistere al momento in cui il mio record sarebbe stato sconfitto da un giovane promettente. Allora io chiesi se la macchina potevo prenderla io, nel caso lui non ci fosse riuscito, ma la risposta fu che non si poteva. Allora chiesi se mi avrebbero dato almeno il portachiavi…che so, una ruota. Ma fecero finta di non capire. In Italia siamo così: invece di difendere i nostri tesori, appaltiamo agli stranieri i lavori del loro abbattimento. Il record, comunque, non fu neanche battuto in quell’occasione”.
Tutti intorno a lui continuano a tesserne le lodi, ma nello storico contesto dell’ex-carcere borbonico di Montefusco, il ragazzo che si guadagnava i primi spiccioli gareggiando con le auto, spesso vincendo, e che fu scartato da quello che qualche anno dopo sarebbe diventato il suo allenatore olimpionico, suggerisce che l’unica buona dose che un buon sportivo dovrebbe farsi è quella di umiltà, e assistere ai suoi risultati è un vero spettacolo.
MARIA ELENA NAPODANO
MARIA ELENA NAPODANO
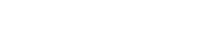
 15/06/2006
15/06/2006












