Idrogeno e bioenergie: le nuove frontiere dell'energia ''verde'' Ambiente

Le alternative a gas e petrolio sono note da anni. Ma i cambiamenti preferiamo subirli piuttosto che governarli. Nel 2014, nel volume ″eccellenze sannite″ raccontavo storie di imprenditori del Sannio impegnati nel fornire ai consumatori risposte energetiche green, performanti ed economiche: dal fotovoltaico all’eolico, dalla geotermia alle biomasse, dal caldo ecologico alle luci al led, dalla fabbrica del futuro alla casa in legno. Davo risalto a soluzioni brillanti ideate da aziende moderne e virtuose del territorio per soddisfare il crescente bisogno di risparmio energetico: la Idnamic ed Elettrosannio a Pietrelcina, De Masi, Pasqualicchio, Seieffe ed Eulux in Valle Caudina, Mitracos Engineering a Morcone, Nuove Architetture a S. Giorgio del Sannio. A distanza di dieci anni, grazie soprattutto alla ricerca accademica, la gamma delle soluzioni si è ulteriormente arricchita con l’idrogeno e le bioenergie: la nuova frontiera delle risorse rinnovabili.
Ne abbiamo discusso con il prof. Francesco Pepe, docente di Impianti Chimici presso il Dipartimento d’Ingegneria dell’UniSannio. “L’idrogeno è un importante ′vettore energetico′, vale a dire, un materiale che può essere utilizzato per trasportare energia da un luogo ad un altro. In questo senso l’idrogeno, sia pure con una serie di limitazioni tecnologiche, è un potenziale concorrente di benzina, gasolio, gas naturale o –per quanto quest’ultimo sia un vettore immateriale– energia elettrica”. Come per l’energia elettrica, dunque, l’idrogeno è un vettore il cui utilizzo non comporta emissioni dirette di anidride carbonica (CO2), cioè quel gas che -come ormai ampiamente dimostrato- ha un impatto diretto sul clima della terra. “Questa caratteristica lo rende tendenzialmente preferibile rispetto a vettori ′fossili′ come benzina o gas naturale”.
Nel lessico giornalistico, l’idrogeno assume diverse… ′colorazioni′: da grigio a verde, da blu a viola. Parliamo dell’idrogeno ″verde″.
È definito idrogeno verde quello prodotto utilizzando fonti energetiche rinnovabili - emettendo, quindi, pochissima CO2. Tra le fonti energetiche rinnovabili, sicuramente rientrano le biomasse di origine agricola e forestale (le piante) dalle quali l’idrogeno può essere ricavato mediante processi –che esistono e sono tecnologicamente maturi– detti di gassificazione e di reforming. L’elemento cruciale, è però quello di gestire in modo sostenibile le biomasse, evitando che la produzione di “bioidrogeno” sottragga biomasse agricole all’alimentazione umana o animale e, inoltre, valutando attentamente i consumi delle altre risorse non rinnovabili (si pensi all’acqua o al suolo) che i processi di produzione potrebbero comportare. Detto questo, mi lasci precisare che il momento nel quale l’idrogeno verde -che lo si produca dalle biomasse o dall’energia elettrica da fonte solare o fotovoltaica- avrà un ruolo significativo nel ′mix′ dei vettori energetici, non mi sembra dietro l’angolo. Magari domani le cose cambieranno, ma suggerirei cautela.
L’idrogeno può trovare invece ′applicazioni′, come sostituto dei combustibili tradizionali, nei trasporti e nell’industria?
Per le prime, il ricorso all’idrogeno verde –tal quale o, più probabilmente, nella forma di materiali ottenuti a partire dall’idrogeno come l’ammoniaca o il metanolo– potrebbe essere un elemento cruciale per la mobilità di sistemi di grosse dimensioni come autocarri, aerei o navi, per i quali l’alimentazione a batteria non mi pare concretamente perseguibile. Per quanto riguarda le seconde, l’idrogeno verde potrebbe sostituire i combustibili fossili per “decarbonizzare” processi essenziali come la produzione di cemento o di acciaio, per i quali l’energia elettrica difficilmente potrebbe sostituire i combustibili fossili attualmente utilizzati. Di nuovo: sono prospettive molto interessanti, ma anche molto costose, sulle quali conviene investire oggi in termini di ricerca&sviluppo per vederle probabilmente in esercizio su grande scala tra qualche decina di anni.
Il futuro della mobilità, affermano i maggiori produttori d’auto, sarà elettrico. È davvero così?
In questo momento storico il ricorso alle batterie elettriche sembra essere la soluzione meno impraticabile (non la più praticabile: la meno impraticabile) per quanto riguarda il funzionamento delle automobili, ma personalmente non sono sicuro che sarà mai possibile utilizzare le batterie agli ioni di litio per elettrificare tutte le auto del mondo, che sono oltre un miliardo. Però la mobilità non è solo quella delle automobili e non credo che vedremo mai una nave portacontainer o un aereo commerciale, alimentati a batteria: il ricorso all’idrogeno e ai combustibili derivati dall’idrogeno, resta decisamente sul tavolo anche nel settore dei trasporti.
Parliamo ora di ″bioenergie″, altra fonte pulita e rinnovabile. Cosa sono e come utilizzarle?
Le bioenergie costituiscono un’ampia gamma di vettori energetici a ridotto impatto sul clima, che va dal noto pellet –o, se è per questo, dalla semplice legna da ardere– a materiali più sofisticati come il bioetanolo, il biodiesel, il biometano e il bioidrogeno. Le tecnologie per produrle sono varie, applicabili a scale diverse. Esistono, inoltre, diverse forme d’incentivazione alla produzione dei materiali che ho ora elencato. Vorrei però cogliere l’occasione che mi sta offrendo per sottolineare che, a mio avviso, nella valutazione dei processi di produzione delle bioenergie andrebbe assolutamente perseguita la netta separazione tra il “circuito” delle biomasse alimentari (intendendo tra queste anche quelle destinate alla zootecnica) e quello delle biomasse ad uso energetico, avendo sempre in mente il fatto che un livello eccessivo d’incentivazione finisce con l’introdurre distorsioni pesanti in un settore delicato come quello agricolo.
Spieghiamolo con un esempio.
Qualche tempo fa lessi un business plan relativo alla produzione di ″barbabietole da zucchero″ nel quale il proponente, abbastanza candidamente, faceva intendere che lo zucchero era un impaccio rispetto al vero obiettivo: generare molti scarti agricoli, da usare per intercettare generosi finanziamenti pubblici esistenti sulla filiera del biogas e del biometano. Ovviamente con questo non mi sogno di criminalizzare chi, da operatore economico attento al contesto nel quale si muove, si attrezza per intercettare i finanziamenti pubblici che sono in campo in un dato settore: alla fine ognuno fa il suo mestiere e gli imprenditori agricoli non debbono e non possono fare eccezione a questa regola.
L’Italia punta anche allo sviluppo dei “biocombustibili”: biometano, bioetanolo e biodiesel.
Sono particolarmente interessanti, in quanto possono essere utilizzati semplicemente miscelandoli coi loro analoghi fossili (rispettivamente gas naturale, benzina e gasolio) e quindi sfruttando infrastrutture di distribuzione già ampiamente sviluppate. I processi di produzione, pur relativamente complessi, sono ormai ampiamente noti e le tecnologie sulle quali sono basati sono facilmente accessibili sul mercato. Personalmente credo che, pure con i paletti che menzionavo prima, la loro produzione vada incoraggiata e, soprattutto, sono convinto che una gestione attenta delle biomasse di scarto -a partire da quelle provenienti dai rifiuti urbani- possa contribuire in modo significativo alla tutela dell’ambiente.
Quale il messaggio che il mondo accademico lancia a produttori e trasformatori della Campania per non subire i cambiamenti della transizione ecologica, ma essere invece pronti a coglierne le opportunità?
Poiché le tecnologie che abbiamo menzionato sono tutte caratterizzate da significative economie di scala –e, d’altra parte, la proprietà agricola in Campania è spesso frammentata- personalmente credo che un elemento cruciale in questo settore sia perseguire forme di organizzazione consortile che consentano ai singoli produttori e trasformatori di mettere in comune materiali che fino a ieri consideravano scarti delle loro attività produttive, così da rendere possibile la realizzazione di centrali di dimensioni adeguate (“bioraffinerie”) per la trasformazione delle biomasse residuali in vettori energetici privi di carbonio d’origine fossile.
GIUSEPPE CHIUSOLO
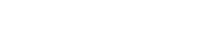
 08/04/2023
08/04/2023












