Anche un 'mi piace' su Facebook puo' costare caro Società

Occorre sempre stare attenti a ciò che diciamo, ancor più a ciò che scriviamo. La libertà di parola e, per esteso, la libertà d’espressione del pensiero sono un bene prezioso. In passato in molti si sono battuti e spesso hanno anche perso la vita perché noi potessimo godere di queste libertà, ma talvolta, credendo che i diritti siano privi di limiti, finiamo per abusarne.
Di recente sono saltati agli onori della cronaca due casi che illustrano molto chiaramente di cosa sto parlando: il leader leghista Matteo Salvini si è visto sospendere temporaneamente la propria pagina Facebook per aver usato il termine “zingari”. A nulla è valso il fatto che tale vocabolo sia d’uso comune e men che meno a sua discolpa ha potuto addurre l’esistenza di una pagina Facebook che ha come fine principale quello di raccogliere insulti contro di lui. A quanto pare, infatti, le regole del noto social network permettono ai comuni utenti d’insultare i vip, ma non ai vip di usare termini spregiativi nei riguardi delle minoranze.
A seguito della sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo sulle violenze alla scuola Diaz nel 2001, un poliziotto ha scritto su Facebook che, se potesse, rifarebbe le stesse cose che ha fatto all’epoca non una, ma mille volte. I superiori di quell’agente hanno sospeso non solo lui, ma persino i colleghi che hanno cliccato mi piace a quell’intervento.
Se ne ricava quindi che non solo possiamo essere chiamati a rispondere di ciò che scriviamo sui social network, ma che addirittura un gesto semplice, elementare come cliccare su “mi piace” può tradursi in una responsabilità civilmente e penalmente rilevante. Molti infatti non si rendono conto che scrivere su Facebook o Twitter non è come fare delle dichiarazioni in un bar, magari dopo aver bevuto un aperitivo di troppo. Verba volant, scripta manent, dicevano gli antichi; e se i Romani erano soliti scrivere sul marmo, tale proverbio è valido anche per noi che scriviamo sui tablet o sugli smartphone: perché la rete, per quanto virtuale possa essere, ha la capacità di rendere i nostri pensieri più indelebili della più dura delle pietre.
In America, dove il politically correct regna incontrastato, una frase sbagliata può costare caro. Ha fatto scuola il caso di una ragazza che, il giorno prima d’iniziare a lavorare, scrisse su Facebook: “Domani è il mio primo giorno di lavoro in quel posto di m…” e poco dopo si trovò a leggere il commento del suo datore di lavoro che diceva: “Invece no: sei licenziata”. Così come perse il posto una p.r. che prima di un viaggio in Africa scrisse su Twitter “Spero di non prendere l’AIDS”.
Dobbiamo capire tutti che sono finiti i tempi di internet 1.0 in cui ognuno si celava dietro un nick e quindi se il tale mazingaz78 (faccio un esempio a caso) scagliava un’invettiva contro i rom, gli immigrati clandestini o banalmente sparava qualche frase razzista, sessista o peggio, poi poteva passare tranquillamente ad altro, senza preoccuparsi delle possibili conseguenze delle sue parole.
Oggi su Facebook ognuno di noi è presente con il proprio nome e cognome, spesso anche con la propria faccia. I nostri interventi possono essere letti da parenti, amici, ma anche dai datori di lavoro e finanche dalle autorità. È quindi un bene se riflettiamo accuratamente prima di scrivere qualunque cosa, perché dopo non potremo accampare scuse o lagnarci di essere stati fraintesi, a meno che non siamo tra i pochi che si possono permettere un portavoce pronto a giurare che le nostre parole vanno contestualizzate.
Saluti dalla plancia,
CARLO DELASSO
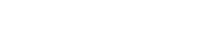
 06/05/2015
06/05/2015














