Psicologia infantile - A colloquio con il dottor Roberto Ghiaccio: ''Il diritto alla noia nei bambini è sacrosanto'' Società

Conoscersi, essere in sintonia con se stessi, fare pace con ciò che ci circonda, ritrovarsi quando ci si perde, rallentare e prendere fiato sono tasselli importanti, vitali per il benessere mentale.
Da un po’ di tempo a questa parte siamo bombardati a tutte le ore da spot pubblicitari su vari medicinali per combattere l’ansia, ma anche su servizi di psicologia online, segno questo di quanto la serenità mentale al giorno d’oggi sia minacciata, intaccata e compromessa a più livelli, in fasce di popolazione sempre più ampie.
“Tutti possono ascoltarti, ma uno bravo sa davvero come aiutarti”, “Per stare meglio, comincia da uno bravo” recitano alcuni di questi spot…
Ebbene, noi uno bravo lo abbiamo incontrato di persona e con lui abbiamo parlato di genitori, figli, mutazioni del cervello, cutters, fino a giungere al triste fenomeno del suicidio tra giovani e giovanissimi.
Si tratta del dottor Roberto Ghiaccio, psicologo clinico e dello sviluppo, specializzato in psicoterapia della Gestalt, in neuropsicologia dei disturbi dell’apprendimento e psicodiagnosi.
Docente presso l’Università Giustino Fortunato di Benevento in neuropsichiatria infantile con il professor Domenico Dragone.
Il dottor Ghiaccio insegna anche in vari master universitari ed è tra gli autori del libro “Linea Guida sulla gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento”.
Redattore di “Psciologinews Scientific”, è altresì responsabile scientifico dell’associazione ADHD Campania (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), formatore AID (Associazione Italiana Dislessia) ed attualmente collabora con l’ASL di Avellino per la NPI di transizione (Neuropsichiatria Infantile).
Motociclista, appassionato di cravatte ed ex giocatore di pallamano, Roberto Ghiaccio, classe 1983, è sposato con un’insegnante di scuola elementare.
Dottore, oggigiorno i genitori tendono a far fare ai propri figli mille attività extrascolastiche. Secondo lei è un bene oppure è un’esagerazione?
Il mondo dell’infanzia attuale è contraddistinto da delle contraddizioni eccezionali, nel senso che abbiamo uno sbilanciamento eccessivo: da un lato il bambino è invitato ad essere prestazionale da un punto di vista accademico e cognitivo, mentre dal lato dello sviluppo umano e morale è sempre più piccolo, sempre meno autonomo, tanto è vero che tra le difficoltà più grandi che si riscontrano c’è il fenomeno della disregolazione, che poi sta alla base di tanti tratti disfunzionali, basti pensare ai bambini autolesionistici. Quello che andrebbe fatto è ridare all’infanzia il diritto fondamentale al gioco, ad annoiarsi, ma bisognerebbe dare ancora di più all’infanzia il diritto alla speranza, inteso come dare al bambino il senso di potercela fare.
Se pensiamo che oggi i nostri bambini sono bombardati dal dover mantenere uno standard molto alto dovendo ottemperare a molteplici attività, c’è il rischio che i bambini non si sentano più riconosciuti per quello che sono, ovvero bambini, e se non si sentono riconosciuti hanno paura di sbagliare e se hanno paura di sbagliare hanno paura di apprendere. Dunque il messaggio che gli educatori, che le persone “grandi” dovrebbero dare a un bambino è la speranza di migliorarsi, ma non solo e soltanto da un punto di vista cognitivo, accademico e prestazionale, ma da un punto di vista socio-emotivo e relazionale, cioè imparare a stare in mezzo agli altri e soprattutto in mezzo agli altri che non sono come noi.
Lei ha detto che tra i diritti fondamentali del bambino c’è anche quello sacrosanto alla noia. Ce lo può spiegare meglio?
La noia fa nascere il gioco libero, il gioco di finzione, quello simbolico e il gioco di fantasia. Pensiamo al bambino piccolo che fa della penna un aereo, della mazza della scopa un cavallo, oppure che fa di un cartone una navicella spaziale.
Sono tutte cose in cui il bambino coltiva la sua fantasia, la sua immaginazione, che non è assolutamente una realtà virtuale, ma è un qualcosa che gli permette di spaziare magicamente da un gioco all’altro. Se il bambino lo adultizziamo, lo rendiamo adultomorfo, nel senso che l’adulto deve essere incasellato, prestazionale, perfettamente medio o allineato, allora al bambino quando gli ricapita più di giocare, scherzare, poter sbagliare senza avere una responsabilità? Perché lo vogliamo già stressare? Il bambino ha il diritto ad essere un infante. Ciò non vuol dire che non debba fare attività come musica, sport, arte o teatro, ma piuttosto che le faccia per divertirsi e non per essere qualcuno, che faccia delle attività per sperimentarsi ed imparare a crescere, ma senza dover essere ossessionato. I bambini devono imparare ad autoregolarsi, cioè a controllarsi soli e più vengono ossessionati da un controllo esterno e meno imparano a controllarsi. Diciamo che si è complicato qualcosa che in realtà è molto semplice e naturale.
La frenesia sembra pervadere tutti noi… Dai piccoli agli adulti si ha sempre fretta. Ma per andare dove?
Il tempo è importante e noi abbiamo affrettato tutto, ma c’è un tempo che è dimenticato ed è quello del gioco, ma non del gioco con i videogiochi o con il tablet, ma del gioco in cui i genitori si mettono a terra, si sporcano insieme ai figli e senza la paura di sporcarsi, importantissimo poi il tempo trascorso insieme a parlarsi. Noi molto spesso assistiamo a genitori che non conoscono i figli e a figli che non conoscono i genitori, il che può essere un bene per gli adolescenti, i quali tendono ad allontanarsi, ma per un bambino piccolo avere un genitore estraneo, che torna tardi a casa, che accontenta, che non tollera il capriccio e zittisce il figlio, ebbene, è drammatico! Stiamo andando verso un’ansia da prestazione. Noi parliamo di emergenze psichiatriche, ma siamo certi che siano delle emergenze, o è tutto previsto e prevedibile? Perché la società è fatta dalle persone e dunque dire: “è colpa del tempo”, o “è colpa della società” è un atto di inumana deresponsabilizzazione. Quello che bisognerebbe fare un attimo è fermarsi, cominciare a giocare, ricominciare a parlarsi, darsi il tempo per conoscersi in qualche modo.
Sempre più smartphone e tablet, invece, vengono usati come babysitter o ciucci digitali…
I nostri bambini non possono essere assolutamente abbandonati al babysitteraggio virtuale, perché questo può finire per aumentare il tratto dell’impulsività, dell’avversità all’attesa, dell’intolleranza alle frustrazioni per volere tutto e subito. Le maggiori indicazioni dei pediatri nelle linee guida internazionali sono per vietare decisamente strumenti tipo smartphone, cellulari e tablet prima dei 6/7 anni e di limitarne l’uso - tra i 7 e i 14 anni - a massimo mezz’ora al giorno.
Nel terzo millennio, quale parte del cervello si sta sviluppando maggiormente e quale invece sta regredendo?
Il nostro cervello è plastico, il fatto che sia plastico vuol dire che l’ambiente esterno riesce a cambiare le connessioni all’interno del nostro encefalo. Un abuso di digitalizzazione provoca un aumento delle aree occipitali, quelle della visione, e di contro una atrofizzazione delle aree frontali, questo porta ad uno squilibrio tra le aree deputate alla percezione e le aree che si occupano di filtrare e di frenare le informazioni. Dalle ricerche di neuroimmagine, ad esempio, sappiamo come un abuso di videogiochi modifichi nel cervello l’area deputata al pollice. Si tratta di un’area molto piccola, situata in un solco che si chiama solco intraparietale, ma l’abuso di videogiochi e di conseguenza il movimento smodato del pollice riesce ad allargare questo solco. Ne consegue la diminuzione di altre aree del cervello. Un’area, ad esempio, che si sta rimpicciolendo è quella del linguaggio, della fonoarticolazione, tanto è vero che, se ci facciamo caso, sta cambiando anche il modo di esprimersi: sempre più veloce, fugace, superficiale e mediato dalle faccine, dalle emoticon, insomma da tutte quelle rappresentazioni che tendono a condensare in un’immagine un pensiero complesso. Stiamo andando verso un cambiamento e non sappiamo dove ci porterà.
E allora che fare?
Forse dovremmo estraniarci un attimo dalla globalizzazione e pensare un poco di più a tutto quello che ci sta intorno; ciò non vuol dire negare come il mondo sia cambiato, ma semplicemente fare maggiore attenzione alle relazioni più prossime a noi. Uno dei più grossi rischi dell’abuso del virtuale è la perdita di empatia. Perché non vedendo l’altro non vediamo neppure la sua sofferenza ed in qualche modo tendiamo a proiettare, a incanalare tutta la nostra rabbia, la nostra invidia, la nostra gelosia verso l’altro. Siamo molto più offensivi, molto più cattivi e tremendi nel commentare e nel giudicare da una tastiera, proprio perché il mezzo ci impedisce di metterci nei panni dell’altro. La sfida è utilizzare gli strumenti digitali, utilizzare l’intelligenza artificiale senza mai spegnere il cervello, però spegnere il cervello è una tentazione che lo strumento dà. Allora, educare a nuove forme di apprendimento sia i bambini che gli adulti è quanto mai necessario.
C’è differenza tra leggere sul cartaceo e leggere tramite dispositivo digitale?
La lettura digitale porta, in maniera innata e parafisiologica, a delle saccadi, ovvero, a dei movimenti degli occhi più veloci. Tecnicamente abbiamo un ancoraggio, un disancoraggio e uno spostamento molto più veloce e molto più lateralizzato sulla sinistra, questo perché la lettura da schermo porta appunto una lettura che si definisce surfata, superficiale, skimmata, saltata, o addirittura ad effe, cioè tendiamo a non leggere tutto il testo, ma lo scorriamo con velocità fino a riconoscere il termine che cercavamo. Invece, con la lettura da cartaceo siamo costretti ad avere una lettura molto più profonda, attenta, molto più umanizzata. Questo è un problema per i bambini che imparano a leggere, in quanto dovrebbero essere bialfabetizzati, ovvero abituati a leggere con la stessa intensità del cartaceo anche sul digitale, ma si parla di educazione a forme di bialfabetizzazione anche per quel che concerne la scrittura. I bambini del resto non nascono imparati.
Lei pensa che la figura dello psicologo sia necessaria tanto nelle scuole, quanto negli ambienti di lavoro?
Sì, ci vorrebbe uno psicologo per la gestione delle risorse dell’umanità dell’altro. Le difficoltà, il panico, la depressione nessuno se le va a cercare ed il nostro compito è proprio quello di metterci all’ascolto dell’altro, non solo e soltanto per un profitto o per avere di più, ma perché ognuno merita una qualità della vita - sia a scuola che al lavoro - che sia quanto più dignitosa possibile.
Il triste fenomeno del suicidio tra i giovani è il tema del suo prossimo libro. Ci può dire qualcosa?
Il libro ha due teste e due cuori: il mio e quello del mio maestro, il professor Domenico Dragone, direttore del Dipartimento di Psichiatria e Neuropsichiatria Infantile dell’Asl di Avellino, oltre a numerosi contributi a cura dei professori Raffaele De Luca Picione, Vincenzo Amarante, Simone Pisano e Antimo Navarra. Si tratta di un manuale diviso in due parti: la prima sulla spiegazione clinica di cos’è la suicidalità, la seconda sui vari indirizzi di psicoterapia che possono dare una mano nella gestione del paziente con suicidalità e, dunque, si parte dai tentativi anticonservativi dei bambini dagli 8 anni sino agli adolescenti. Purtroppo, siamo di fronte ad una realtà difficile, carica di insicurezze, sintomatologie così complesse che si definiscono transdiagnostiche. Sta crescendo il numero dei bambini con disturbo da disregolazione dell’umore e del comportamento, che mettono in atto tentativi anticonservativi, cioè tendono a farsi del male. Poi ci sono tutti quei soggetti che non hanno un disturbo del neurosviluppo, ma che in seguito ad una crisi sono portati a svilupparlo, questo succede soprattutto tra gli adolescenti ed uno dei fenomeni più caratteristici che riscontriamo e quello del cutting, cioè gli adolescenti che si tagliano. Una ferita sulla pelle che paradossalmente diventa una feritoria, perché i teenagers non si tagliano per il piacere di farlo, quanto per far uscire la loro sofferenza fuori e se noi quella ferita tendiamo solamente a chiuderla, a nasconderla, ma non a vedere la comunicazione che c’è in quel taglio, amputiamo ogni possibilità di crescita. Nel libro prendiamo in considerazione il punto di vista di colui che vuole morire, ossia, non per la contentezza di morire, ma perché non vuole più vivere. Allora, il nostro compito non è quello di condannare il tentativo di suicidio, quanto comprenderne il motivo. La soluzione è che dobbiamo intercettarli, accompagnarli e non solo curare la persona, ma curare anche l’ambiente che ha portato a una decisione del genere e le terapie variano da caso a caso.
ANNAMARIA GANGALE
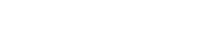
 23/11/2023
23/11/2023














