I nostri 150 anni Società
Il prossimo 17 marzo sarà una giornata di festa nazionale. Si chiamano così – festa nazionale – quelle ricorrenze particolarmente legate a episodi costitutivi della nostra identità, ideali simboli unificanti, rari esempi di idem sentire, tappe fondamentali di un cammino comune.
Le istituzioni dell’Italia repubblicana non hanno esitato a richiamare alla memoria collettiva il debito di riconoscenza che si deve alla Monarchia e ai Savoia, protagonisti di un evento che 150 anni fa segnò nel libro della storia la nascita di un nuovo stato nazionale, il Regno d’Italia.
In un paese che ha conosciuto le tristi conseguenze di una moda scellerata, quasi una ubriacatura, sintetizzata nel termine discontinuità, ricordare chi ci ha consentito di ostentare un legittimo orgoglio è segno di cavalleresca riconoscenza e auspicio di rinsavimento.
Il tempo della storia si misura all’ingrosso. Una volta si andava a secoli. Poi ci siamo accorti che anche i decenni ci hanno consegnato cambiamenti e nuove prospettive. Uno storico inglese ha escogitato una definizione fortunata per il 1900, allorché si è accorto che i cento anni che concludono il secondo millennio non possono essere rappresentati sotto un’unica etichetta, tanto gravi e contraddittorie sono state le sue fasi e tanto sfaccettata la sua storia. Di qui la necessità di racchiudere una fase unitaria, sia pure per i mille travagli in essa contenuti, nel titolo di “secolo breve”.
Anche i nostri 150 anni non sono stati un percorso lineare. Essi vivono la eredità di cui sono costituiti con i colori di Arlecchino dei precedenti storici, dove Arlecchino non è un’offesa, ma il richiamo pittoresco alla ricchezza di costumi, di culture, di tradizioni, di economie, in una parola di storie, che hanno contraddistinto la vita delle comunità che hanno abitato questa lunga penisola spaparanzata nel mare Mediterraneo.
La creazione del Regno d’Italia non chiude al passato. Apre al futuro, portando con sé tutte le differenze (e le diffidenze), tutte le esperienze istituzionali, tutti i conflitti non ancora composti, di una storia fatta di guelfi e ghibellini, di comuni, ducati e principati. Dalla caduta dell’Impero Romano d’Occidente (476 dopo Cristo), quella che chiamiamo Italia ha vissuto una esperienza singolare: la coabitazione di una autorità spirituale (e per certe zone anche politica) e di una infinità di autorità politiche insediatesi in territori ora ristretti ora più ampi. In nessuna di queste esperienze politiche, tuttavia, può dirsi si siano insediati regimi tirannici. L’esperienza dei comuni ha collaudato forme di partecipazione delle rappresentanze. Proprio l’apparente mancanza di unitarietà (meglio si direbbe, di uniformità) ha mantenuto viva presso le classi colte e presso gli operatori economici (i mercanti, i banchieri, i proprietari dei beni primari) l’abitudine alla competizione, l’allenamento alla composizione dei contrasti, lo spirito di adattamento che tante volte siamo soliti bollare in negativo come elementi costitutivi del carattere degli italiani.
Il Regno d’Italia non abolisce le differenze. Detta una strategia per presentare un bilancio comune, che non è la somma dell’esistente, ma una scommessa nuova alla quale chiama a giocare una popolazione numericamente ragguardevole, comparabile con quella degli stati già costituitisi.
Che il progetto fosse ancora da perfezionare, ma era chiaro nella mente di Cavour e Vittorio Emanuele II (e di Mazzini e di Garibaldi), lo ricordano le migliaia di nomi che in ogni comune d’Italia sono incisi nel marmo per aver dato la vita nella prima guerra mondiale. Fu, la guerra, il più probante certificato di collaudo per il giovane Stato. Non tanto per la vittoria, che alcuni ritennero “mutilata”; quanto perché nelle trincee e nei mesi lontani da casa, si conobbero fra loro, impararono a capirsi, si stringevano negli abbracci e piangevano in silenzio gli italiani di ogni latitudine. In una parola condividevano (cioè dividevano insieme) quel che di più prezioso sentivano di avere, la vita. E quel che la vita significa, quando la si perde: la morte.
Non mancarono, di lì a poco, altre prove. E fu ancora una volta una tragedia, ancora più immane, ancora più disumana. Le seconda guerra, l’altra guerra. Si moltiplicarono per dieci i morti, si moltiplicarono per mille le vittime civili uccise a centinaia e migliaia di chilometri dal fronte. Si conobbero il disonore e l’immoralità, la fame e la miseria. Curzio Malaparte, che pure era stato sostenitore di Mussolini, raccontò ne La Pelle quello che aveva visto. Eduardo De Filippo, nello strazio del riso, intuì in Napoli Milionaria che nulla sarebbe stato come prima: la guerra non è finita e non è finito niente.
L’8 settembre fu per noi italiani una seconda edizione di Caporetto, senza il lieto fine. E pure dalla guerra perduta uscì un popolo capace di farsi guidare verso la riconquista della dignità. Con il lavoro, con l’onestà, con la rettitudine. Fu chiamato il miracolo economico, era il miracolo italiano.
La Monarchia, che aveva solennizzato il processo unitario, usciva di scena accettando il verdetto della storia. Assisteva, tutto sommato, all’esame di maturità del suo popolo, che seppe leggere il vento muovo della libertà la quale muoveva le bandiere dei vincitori che si sarebbero presi cura di noi dopo averci dato la severa lezione del trattato di pace di Parigi.
In questa storia, si iscrive la parabola di Benevento. Città dal passato insigne (anche i francesi di Gioacchino Murat, quando la occuparono, non la aggregarono al Regno di Napoli, riesumando per essa lo status di Ducato), fu riconosciuta titolare del diritto di guidare un territorio. Nacque così la Provincia di Benevento, con il sacrificio delle province contermini del Regno delle Due Sicilie.
Non fosse che per solo questo iniziale privilegio, dovremmo riconoscere al 17 marzo i connotati di una festa anche nostra: di sanniti, intendo, non solo di italiani.
Anche se tante volte anche noi siamo caduti nella tentazione di recriminare per torti o mancati riconoscimenti, il bilancio di questo secolo e mezzo ci pare tale da meritare una valutazione positiva.
Anche perché Vittorio Emanuele e Cavour caricarono la molla. Ma, poi, tra inciampi e decisioni felici, il cammino lo hanno fatto i nostri nonni e i nostri padri. Un tratto l’abbiamo fatto pure noi.
Alla festa, insomma, non siamo solo invitati. Siamo pure i festeggiati.
Mettiamoci, allora, il vestito buono, orgogliosi di poter passare la mano alle giovani generazioni, con l’augurio che tutto gli riesca meno doloroso.
MARIO PEDICINI
mariopedicini@alice.it
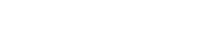
 03/03/2011
03/03/2011













