Quando si mangiava in bianco Cultura

I gastronomi dei secoli scorsi, dal romano Apicio all’Artusi, erano convinti che le ricette importate dal mondo arabo fossero adatte soltanto a chi riusciva ad abituarsi a certi sapori. Ma esplorando nella Bibliothèque Nationale di Parigi e nella Biblioteca Apostolica Vaticana i rari manoscritti di cucina pervenutici dal Medioevo, citati da pochi e letti da nessuno, si scopre che anche alcuni piatti della nostra tavola familiare sono di antica origine mediorientale o africana. Quei testi andrebbero tradotti e divulgati, soprattutto per… far evitare gli chef pseudoraffinati che oggi propinano purea speziata di fagioli e patate rosse come ‘recupero della tradizione medievale’ a chi è ignaro della loro origine americana!
Già nei secoli VI-XI la Longobardia beneventana importò ricette dall’impero islamico, dominato fin dal 750 dalla dinastia califfale. Nel Duecento, poi, Federico II di Svevia, imperatore di Germania e re dell’Italia meridionale, introdusse altri elementi della cultura araba nella sua corte palermitana, dove piatti mediorientali venivano serviti mentre si esibivano danzatrici saracene e suonatori di strumenti mai visti in Europa. Anche suo figlio, il re Manfredi di Svevia ucciso a Benevento nel 1266 dalle truppe di Carlo d’Angiò, mangiava alla maniera araba: sfoglie di pasta cotte con legna aromatica ripiene di riso e fave fresche, minestre di verdure con uova olive noci e uva passa, zeppoline fritte, spiedi di carni varie affettate con la spada. Il tutto reso piccante dal pepe nero. I due sovrani orientarono così la gastronomia del sud Italia in senso più ampiamente mediterraneo.
Tra i manoscritti medievali della Biblioteca Vaticana, la mia attenzione è andata al Manoscritto Palatino Latino 1768 contenente il Liber de coquina, composto da un ignoto personaggio della corte sveva. Riporto qui la ricetta di un sughetto arabo, scritta nel latino parlato dalle nostre parti nel Duecento: “Suffrige cipolas cum oleo et mite in aqua bulienti, decoque et super pone species, et colora et assapora sicut vis, cum istis pones caseum grattatum vel incisum, et da quandocumque placet cum capones et cum ovis vel quibuscumque carnibus”. Vale a dire: “Soffriggi cipolle in olio, allunga con acqua bollente e cuoci a fuoco lento, spargici sopra colorate spezie piccanti assaporando come vuoi, e sul tutto metti cacio grattugiato o trinciato, poi aggiungi a piacere erbe aromatiche, uova e carni di ogni d’ogni tipo”.
Si tratta della più antica ricetta della salsa che chiamiamo ‘alla genovese’, un condimento comune nel Sud Italia ma sconosciuto proprio a Genova, anzi da Roma in su. Prima della scoperta dell’America e del pomodoro, cioè fino a quando si è mangiato in bianco, alla tavola di re Manfredi quel sughetto arabo dal forte sentore di cipolla in stufato di carni serviva per insaporire tagliatelle dal bordo ondulato, quelle che a Napoli si chiamano tuttora ‘manfredi’.
Quanto alle carni, predominava l’agnello come in tutto il Mediterraneo, ma sulle mense dei nobili era immancabile la cacciagione. Del resto, proprio l’imperatore Federico II scrisse il De arte venandi cum avibus, un trattato di caccia col falco. Conservato nel Codice Palatino 1071 della Biblioteca Vaticana, quel testo è illustrato da miniature di addestratori di falchi sorprendentemente analoghi al Falconiere di Benevento (foto), la statua che dall’alto della facciata duecentesca della nostra Cattedrale guarda da secoli i passanti che non la guardano mai.
ELIO GALASSO
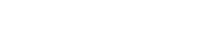
 05/06/2015
05/06/2015














